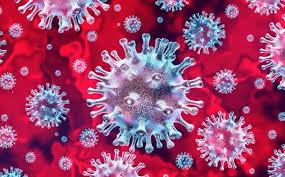 DI LUCA DE FIORE
DI LUCA DE FIOREDic. 15, 2021
“Certe immagini sulla pandemia ti fanno venire voglia di parlare di qualcosa di cui non avresti voluto più parlare”. Ha ragione Walter Guadagnini, uno dei più conosciuti critici d’arte italiani. Uscire dalla pandemia è possibile solo mostrando a noi stessi di essere capaci di conservare nella memoria e dare senso a ciò che abbiamo attraversato, riuscendo a dare risposta ad immagini viste negli ultimi due anni che continueranno ad interrogarci.
Pensiamo per esempio al video – scomposto da subito in una serie di immagini – della fila dei camion che attraversa Bergamo. Il supporto dei mezzi militari era stato richiesto per trasportare le salme di persone decedute per covid verso crematori del nord Italia. Ripreso da un assistente di volo di Ryanair il 18 marzo 2020, è trasmesso sui canali web di Sky e di molti media statunitensi. È un’Italia notturna, quella che fa il giro del mondo. Molto simile a quella fotografata da Alex Majoli nel suo viaggio al contrario dalla Sicilia verso Roma, poi Milano e infine la Slovenia documentando la tragedia. Una lunga notte, quella del covid: lo ha pensato – e detto – anche Roberto Speranza, Ministro della Salute, immaginando che i vaccini potessero portare l’alba.
Un mondo talmente buio, quello della pandemia, che il famoso fotografo francese Antoine D’Agata ha scelto di realizzare un progetto – Virus –usando una fotocamera termica a raggi infrarossi, costruendo immagini incredibili di sagome di malati luminescenti (immagine in alto). “Non avevo assolutamente idea di come documentare la paura, l’angoscia e il dramma”, ha spiegato D’Agata in un incontro al festival Fotografia europea di Reggio Emilia. “Il mio desiderio era comunque quello di documentare la situazione senza pregiudizi o preconcetti. Per questo sono sceso in strada, cercando di privilegiare il più possibile lo specifico del mezzo fotografico, la camera a infrarossi. Documentare il calore dei corpi significava rappresentare qualcosa che non potevamo vedere. Pensiamo però che nel marzo del 2020 per strada non avevamo nulla da guardare: non restava che cercare qualcosa all’interno delle persone che potevamo incontrare negli ospedali, documentando il lavoro delle unità di emergenza”.
Documentare il calore dei corpi significava rappresentare qualcosa che non potevamo vedere.
Durante i primi mesi della pandemia l’ospedale avrebbe potuto diventare un luogo di ricerca non soltanto clinica, ma anche documentale e, per certi aspetti, artistica. Da subito, tuttavia, sono emerse tensioni tra il desiderio di dare testimonianza della tragedia in corso e la volontà di proteggere la riservatezza del dolore dei malati e degli operatori sanitari: l’amministrazione statunitense ha emesso delle linee guida molto restrittive, anche per ridurre l’impatto che immagini troppo forti avrebbero potuto avere sui cittadini americani. “Le statistiche da sole, per quanto chiare, non sono storicamente il modo in cui abbiamo comunicato una calamità su questa scala”, ha scritto sul New York Times Sarah Elizabeth Lewis. “C’è una relazione inversa tra grandezza dei numeri e comprensione dei fenomeni: è molto più difficile immaginare una tragedia come quella a cui stiamo assistendo che guardare una persona che soffre o accostarci ad un’immagine che si collega a un aspetto della condizione umana che ci è familiare”. È l’effetto della vittima che possiamo identificare, precisava la docente di Storia ad Harvard.
“Ho lavorato sessanta giorni per 12 ore al giorno senza fermarmi mai”, racconta D’Agata. “Prima di entrare negli ospedali ho fotografato molto anche per strada e la soluzione tecnologica trovata mi ha messo al riparo dal rischio della riconoscibilità delle persone. Questo mi ha permesso di concentrarmi sulla relazione tra i corpi, sull’empatia del sentire la spiritualità dei corpi, arrivando a percepire la loro sacralità senza distrazioni. Penso che diverse immagini abbiano un non so che di magico. Merito della macchina, ma anche dello sforzo del gesto di andare verso corpi chiusi per effetto del lockdown”.
È molto più difficile immaginare una tragedia come quella a cui stiamo assistendo che guardare una persona che soffre.
Una volta completato il lavoro nei centri ospedalieri, D’Agata è stato impegnato nella preparazione del libro autoprodotto. Una decisione nata dal desiderio di evitare negoziazioni con le case editrici, troppo attente a suo giudizio agli aspetti economici dei progetti. Il desiderio di dialogare direttamente con chi guarda le immagini da lui realizzate è un determinante del lavoro del fotografo francese: “Sono contento di aver potuto colpire chi guarda il réportage Virus con qualcosa di profondamente emotivo. È una maniera strana di fare il mio lavoro, ma molto diretta”.
“Nel volume troverà spazio anche la documentazione del lockdown” – spiega – “ma resta il fatto che ciò che mi ha più interessato è stato ridurre la malattia alla sua più estrema evidenza biologica”. Il lavoro di Antoine D’Agata è dichiaratamente sperimentale, tipico di una persona “in perenne crisi esistenziale, alla ricerca di una posizione originale” di fronte a ciò che osserva nel mondo. Un lavoro che interpreta in modo originale la sempre più diffusa tentazione di contaminare mondo reale e mondo iconico, lasciando che tra i due sia sempre agibile un varco, un potenziale attraversamento che ci permetta di interrogare l’immagine e – come dicevamo in apertura – esserne interrogati.
Articolo tratto dalla Newsletter “Senti chi parla”
Il Pensiero Scientifico Editore.




